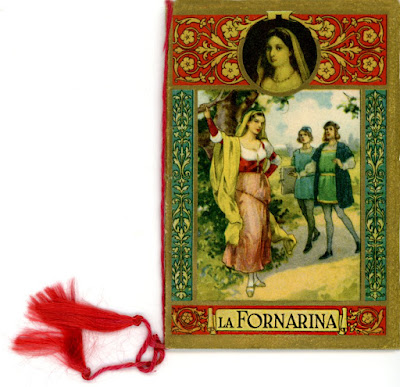Vi parleremo di un mistero che affonda le sue radici in una nebbiosa linea di confine tra paganesimo e credenze popolari le quali non potevano di certo restare immuni all'influenza religiosa. Senza tempo, ne troviamo ancora oggi, infatti, credenze e protagoniste. Gli uomini, per lo più, si trovano coinvolti, sporadicamente e solo nella veste di “pazienti”.
Vi parleremo di un mistero che affonda le sue radici in una nebbiosa linea di confine tra paganesimo e credenze popolari le quali non potevano di certo restare immuni all'influenza religiosa. Senza tempo, ne troviamo ancora oggi, infatti, credenze e protagoniste. Gli uomini, per lo più, si trovano coinvolti, sporadicamente e solo nella veste di “pazienti”.
Forse tradizionalmente solo le donne possono, per la loro natura, eseguire determinati riti, forse perché più legate a ciò che non si vede ma si sa, a quello che non deve essere spiegato, ma si accetta come una cosa di fatto, quasi come un dogma, sancito da chissà chi, chissà quando.
A Mazara del Vallo erano tantissime le donne che praticavano questi "rimedi" chiamati naturali erroneamente, perché di naturale hanno ben poco; la loro spiegazione scientifica avrebbe bisogno di un ingente sforzo di ragionamento e di logica deduttiva.
Quasi una a famiglia, solitamente la più anziana, veniva vista come i guaritori indiani, colei che a tutto aveva una risposta, specie alle questioni mediche e poco comprensibili legati al soprannaturale, praticava anche moltissimi rimedi naturali che ora la medicina ufficiale sembra tornare a guardare, decenni fa si era già capito che molti farmaci contenessero delle sostanze dannose, quindi meglio affidarsi alle cure naturali. Si usava l'aglio come antibatterico, il miele e il limone per dare sollievo alla tosse, il pane cotto ancora caldissimo avvolto in un canovaccio sull'addome per lo stomaco raffreddato, a questi rimedi si affiancavano altri a cui molti, specie i bambini, si sottoponevano: chi di noi non è mai stato sotto effetto “scantu”?
 Poteva sopraggiungere facilmente e per svariate cause, e infiniti e misteriosi erano i sintomi che potevano scatenarsi, il rimedio più usato era “lu bicchiereddu di scantu”, vino rosso con il carbone che prima si accendeva e lo si faceva spegnere all'interno del bicchiere, da bere con tre sorsi accompagnati a tre pezzettini di pane rigorosamente a digiuno, che calmava temporaneamente il soggetto. Ma se lu scantu era grave ci voleva per forza la "calata di stommacu" e così ci si rivolgeva, e ci si rivolge ancora oggi ma più sporadicamente, data la rarità delle persone che la eseguono, alla donna che la sapeva eseguire.
Poteva sopraggiungere facilmente e per svariate cause, e infiniti e misteriosi erano i sintomi che potevano scatenarsi, il rimedio più usato era “lu bicchiereddu di scantu”, vino rosso con il carbone che prima si accendeva e lo si faceva spegnere all'interno del bicchiere, da bere con tre sorsi accompagnati a tre pezzettini di pane rigorosamente a digiuno, che calmava temporaneamente il soggetto. Ma se lu scantu era grave ci voleva per forza la "calata di stommacu" e così ci si rivolgeva, e ci si rivolge ancora oggi ma più sporadicamente, data la rarità delle persone che la eseguono, alla donna che la sapeva eseguire.
Credenti o no non possiamo non riconoscere la disponibilità, a mettere a disposizione il suo tempo, la sua casa e le sue conoscenze, come un medico, non poteva non esserlo! "Lu scantatu" veniva fatto sdraiare su un lettino, gli si faceva scoprire “la vucca di lu stommacu” che per chi non lo sapesse corrisponde alla parte alta dell'addome sotto lo sterno: L'esecuzione corrispondeva a una sorta di massaggio circolare eseguito con l'olio al quale si univa il movimento a croce del pollice, per poter alleviare e allontanare lu scantu , in alcuni casi una sola seduta non bastava e bisognava tornare per altri giorni. Molte erano le varianti, chi prima si faceva il segno della croce, chi lo faceva fare anche a tutti i presenti, per poter iniziare a recitare le "razioni", queste sono la chiave, per molti, del mistero, venivano sussurrate, tramandate solo a determinati soggetti scelti in base a delle caratteristiche stabilite e valutate da chi le doveva insegnare.
Le "razioni" altro non sono che orazioni, l'etimologia ci rimanda al latino oratio che significava discorso, ma venne usato dagli scrittori cristiani del tempo con il significato di preghiera, e forse a quest'ultima accezione si avvicinano le razioni delle nostre donne, spesso parole semplici per chi ha potuto carpirne qualcuna tra quei bisbiglii, alcune nominavano un santo, per affidargli la cura del paziente, ma chiedere di rivelare il contenuto della litania il più delle volte è come provare a farsi svelare una ricetta da uno chef, una mission impossible!
Non tutte però erano state iniziate ad un'altra procedura molto in voga nei mesi più caldi, la "livata di suli 'ntesta". Togliere il sole dalla testa in seguito ad un'insolazione era un rito stupefacente, chi dopo essersi esposto al sole presentava un forte mal di testa andava alla ricerca di chi potesse eseguire l'azione. Questa necessitava di un piatto con dell'acqua, un bicchiere, olio, cotone e un accendino, l'esecuzione era al tramonto, quando il sole va a dormire, forse per fargli portare con sé quello che aveva lasciato sul soggetto, forse per ingannarlo, immancabile era una stoffa rossa apposta sulla testa del paziente, il piatto con dell'acqua lo si poggiava sopra, veniva intinto un batuffolo di cotone in un po' d 'olio d'oliva, lo si accendeva e lo si inseriva nel bicchiere che veniva poi capovolto dentro al piatto, la fiamma consumava l'ossigeno che c'era dentro al bicchiere e l'acqua, che bagnava solo la base del batuffolo veniva risucchiata all'interno del bicchiere stesso, veniva ripetuto per tre volte, e per tre giorni almeno o sette, l'importante è che siano una quantità di giorni dispari, si doveva arrivare al punto che l'acqua non veniva più risucchiata dal bicchiere, a quel punto si era guariti.
Anche qui le razioni erano l'elemento cardine e misterioso, sicuramente diverse dalle altre, perché era obbligo specificare cosa si volesse andare a curare.
 Come in un'escalation verso il paranormale, ancora di meno erano coloro le quali erano specializzate e abilitate ufficialmente a togliere il "malocchio", conosciuta quasi esclusivamente come pigghiata d'occhiu, questa era una scienza che prevedeva a parte l'esecuzione anche l'interpretazione del risultato che si affiancava sempre ad una sorta di indagine da parte del soggetto che la subiva. Anche qui un piatto con dell'acqua, una stoffa rossa da apporre sul capo, come da filtro, si sa il rosso scaccia il male, il piatto sulla testa veniva tenuto con una mano dalla donna, dopodiché iniziava il rito, il segno della croce anche sul piatto come a benedirlo, l'inizio delle "razioni", con la mano libera poi prendeva la bottiglia con l'olio di oliva, e solo d'oliva che per il suo legame con la religione di certo era il più adatto ad aiutare l'allontanamento del malocchio, l'olio veniva versato a piccole quantità dentro il piatto sempre tre volte e spesso con un segno della croce tra una volta e l'altra, in base a come si distribuiva l'olio poteva essere necessario farlo per un totale di nove volte sempre divise a tre a tre. Solo la donna poteva interpretare il risultato del piatto, ci voleva esperienza ma anche una dote innata, innanzitutto se l'olio dopo esser affondato tornava a galla era già un segno positivo, se restava in fondo voleva dire che il malocchio c'era, era potente e le preghiere non sono state sufficienti per contrastarlo, quindi si doveva tornare di nuovo a farlo l'indomani, se l'olio in superficie era compatto, i sintomi quali mal di testa, nausea, svenimenti, non potevano essere attribuita al malocchio, ma la maggior parte delle volte salendo a galla di spandeva su vari livelli, formando all'interno della chiazza un cerchio, un occhio che poteva essere bianco, o con un alone di olio all'interno, un malocchio più debole. Poi si guardava la quantità e il raggruppamento degli occhi, se erano tanti corrispondevano o alla quantità di persone che lo avevano causato o alla quantità delle volte, il raggruppamento suggeriva che quelli che avevano lanciato il malocchio appartenevano ad una sola famiglia, e da qui iniziava l'indagine per capire chi o quando si era stati vittime di malocchio, mentre il paziente indagava magari con l'aiuto di un familiare. La donna terminava il rito, aggiungeva del sale nel piatto, altro elemento molto presente, eseguendo il segno della croce, poi si affacciava dalla finestra o sull'uscio della porta e veniva buttato fuori, magari un po' più lontano dalla propria abitazione e quando la strada non era trafficata.
Come in un'escalation verso il paranormale, ancora di meno erano coloro le quali erano specializzate e abilitate ufficialmente a togliere il "malocchio", conosciuta quasi esclusivamente come pigghiata d'occhiu, questa era una scienza che prevedeva a parte l'esecuzione anche l'interpretazione del risultato che si affiancava sempre ad una sorta di indagine da parte del soggetto che la subiva. Anche qui un piatto con dell'acqua, una stoffa rossa da apporre sul capo, come da filtro, si sa il rosso scaccia il male, il piatto sulla testa veniva tenuto con una mano dalla donna, dopodiché iniziava il rito, il segno della croce anche sul piatto come a benedirlo, l'inizio delle "razioni", con la mano libera poi prendeva la bottiglia con l'olio di oliva, e solo d'oliva che per il suo legame con la religione di certo era il più adatto ad aiutare l'allontanamento del malocchio, l'olio veniva versato a piccole quantità dentro il piatto sempre tre volte e spesso con un segno della croce tra una volta e l'altra, in base a come si distribuiva l'olio poteva essere necessario farlo per un totale di nove volte sempre divise a tre a tre. Solo la donna poteva interpretare il risultato del piatto, ci voleva esperienza ma anche una dote innata, innanzitutto se l'olio dopo esser affondato tornava a galla era già un segno positivo, se restava in fondo voleva dire che il malocchio c'era, era potente e le preghiere non sono state sufficienti per contrastarlo, quindi si doveva tornare di nuovo a farlo l'indomani, se l'olio in superficie era compatto, i sintomi quali mal di testa, nausea, svenimenti, non potevano essere attribuita al malocchio, ma la maggior parte delle volte salendo a galla di spandeva su vari livelli, formando all'interno della chiazza un cerchio, un occhio che poteva essere bianco, o con un alone di olio all'interno, un malocchio più debole. Poi si guardava la quantità e il raggruppamento degli occhi, se erano tanti corrispondevano o alla quantità di persone che lo avevano causato o alla quantità delle volte, il raggruppamento suggeriva che quelli che avevano lanciato il malocchio appartenevano ad una sola famiglia, e da qui iniziava l'indagine per capire chi o quando si era stati vittime di malocchio, mentre il paziente indagava magari con l'aiuto di un familiare. La donna terminava il rito, aggiungeva del sale nel piatto, altro elemento molto presente, eseguendo il segno della croce, poi si affacciava dalla finestra o sull'uscio della porta e veniva buttato fuori, magari un po' più lontano dalla propria abitazione e quando la strada non era trafficata.
La procedura che coinvolgeva spessissimo i più piccoli era la "tagghiatina di li vermi".Nello stomaco si diceva ci fosse una sorta di sacca di vermi che in seguito ad uno scantu, ma non per tutti, o semplicemente perché capitava che succedesse, venivano “smuvuti”, palesandosi con inappetenza (fonte di gravissima ansia per mamme e nonne) e mali diffusi, anche qui non tutte erano abilitate a guarire chi ne era affetto, e si partiva alla ricerca tramite passaparola, di chi sapesse tagliare i vermi, forse si intendeva calmarli, ma ciò che si intendeva, ciò che era e ciò che si diceva non dovevano per forza coincidere, e non ci si prendeva nemmeno la briga di capire e fare domande, l'importante era che il malato stesse bene.
Questi riti e queste credenze non sono esclusive di Mazara, ma le troviamo diffuse specie nel sud, non solo d'Italia, con moltissime modalità di esecuzione, c'è chi toglie il malocchio con un peperoncino, con l'aglio, con un corno, con il sale tenuto in una mano che viene avvicinata prima sulla testa del malcapitato e poi viene spruzzato su una fiamma.
Qualunque sia la posizione della gente riguardo questi argomenti, non bisogna ignorare il fatto che ha coinvolto specialmente in passato una gran fetta della popolazione, e non si può parlare di Mazara e i suoi misteri prescindendo questi fenomeni le cui radici hanno portato a modi di vivere e di pensare i cui frutti li possiamo osservare anche oggigiorno.
Il mondo clericale, a ragione, si trova lontano da questo tipo di cultura che tuttavia coinvolge la religione come in una personale e intima applicazione, infatti una forte fede è una delle caratteristiche della maggior parte delle donne coinvolte in queste procedure, vista come una garanzia della riuscita del loro operato.
Rosa Maria Alfieri
Lu Leccu (L'eco)
“Lu leccu mi rissi chi me figghiu sta bbeni” “La littra arriva dumani- E cu ti lu rissi? – Lu leccu”. Frasi di un tempo che fu, frasi che non si sentono più, frasi di chi andava alla ricerca di una conferma che la sua speranza non era vana. Espediente di un tempo senza fili né Wi-Fi, la risposta ad alcune domande si cercavano in quel Google che sa di mistico e misterioso. Ma cos’era “lu leccu”, ovvero lu “l’ecu”, l’eco, noi ne comprendiamo la natura tramite una spiegazione scientifica che ce lo presenta come il ritorno delle onde sonore, per “lu leccu”, il senso era lo stesso ma non come ci potremmo immaginare, infatti l’eco che si andava ad ascoltare era il ritorno della voce di chi stava dando una risposta a chi poneva la domanda. Ma allora c’era una sorte di indovina a cui rivolgerle? No, la risposta la davano ignari passanti.Il posto era fisso, il luogo dell’eco era nell’incrocio tra Via Valeria e Corso Armando Diaz (vedi foto), dove adesso c’è un piccolo slargo addobbato con piante e panchine accanto ad una edicola votiva dedicata alla Madonna, prima lo spazio era occupato da un edificio e l’edicola votiva era quella del cavaliere San Giorgio, forse il luogo delle risposte è stato proprio scelto per la presenza del Santo a cui ci si rivolge anche quando si vogliono sapere delle risposte tramite i sogni, infatti una filastrocca-preghiera recita così:“San Giorgiu cavalierivui siti a cavaddu e iu a peri,pi la vostra santitàpurtatimi insonnu sta virità.”

Quindi forse si affidavano le domande in quel posto ove il santo aveva l’edicola votiva come se tutto intorno ci fosse la sua influenza e desse il potere a chi passava da lì, di poter dare inconsapevolmente delle risposte a chi era venuto con delle domande nel cuore. Pertanto si stava in attesa che qualche passante pronunciasse quella frase che coincideva con una risposta plausibile per la domanda che attanagliava. Via via con il tempo l'usanza ha perso i suoi praticanti, dapprima è stato abbandonato il posto anche perché l’edicola adesso ha un altro soggetto, e si è diffuso per tutta Mazara, capita che parlando con qualcuno, specie avanti con l’età, magari ponendo una domanda, si senta una frase che sembra proprio coincidere con la risposta che ci si aspetta proveniente da qualcuno che transita, o che parla al telefono, e ci si sente dire poi: “lu leccu t’arrispunnì!”. Veniva visto come di qualcosa di soprannaturale, e quindi corrispondente a verità, perché le coincidenze non vengono percepite altrimenti, c’è sempre una spiegazione a tutto, e il più delle volte tende verso l’ignoto.Chissà se ancora qualcuno si affida all’eco, o se ne accorge se dovesse capitare. Credenti o no, conoscere questi piccoli "fenomeni" aprendo una finestra sul nostro passato ci permette di perpetrare quello che siamo stati, per magari meglio comprendere alcuni aspetti del presente, mai guardare indietro se non con tenera voglia di capire.
Rosa Maria Alfieri





 Vi parleremo di un mistero che affonda le sue radici in una nebbiosa linea di confine tra paganesimo e credenze popolari le quali non potevano di certo restare immuni all'influenza religiosa.
Vi parleremo di un mistero che affonda le sue radici in una nebbiosa linea di confine tra paganesimo e credenze popolari le quali non potevano di certo restare immuni all'influenza religiosa.  Poteva sopraggiungere facilmente e per svariate cause, e infiniti e misteriosi erano i sintomi che potevano scatenarsi, il rimedio più usato era “lu bicchiereddu di scantu”, vino rosso con il carbone che prima si accendeva e lo si faceva spegnere all'interno del bicchiere, da bere con tre sorsi accompagnati a tre pezzettini di pane rigorosamente a digiuno, che calmava temporaneamente il soggetto. Ma se lu scantu era grave ci voleva per forza la "calata di stommacu" e così ci si rivolgeva, e ci si rivolge ancora oggi ma più sporadicamente, data la rarità delle persone che la eseguono, alla donna che la sapeva eseguire.
Poteva sopraggiungere facilmente e per svariate cause, e infiniti e misteriosi erano i sintomi che potevano scatenarsi, il rimedio più usato era “lu bicchiereddu di scantu”, vino rosso con il carbone che prima si accendeva e lo si faceva spegnere all'interno del bicchiere, da bere con tre sorsi accompagnati a tre pezzettini di pane rigorosamente a digiuno, che calmava temporaneamente il soggetto. Ma se lu scantu era grave ci voleva per forza la "calata di stommacu" e così ci si rivolgeva, e ci si rivolge ancora oggi ma più sporadicamente, data la rarità delle persone che la eseguono, alla donna che la sapeva eseguire. Come in un'escalation verso il paranormale, ancora di meno erano coloro le quali erano specializzate e abilitate ufficialmente a togliere il "malocchio", conosciuta quasi esclusivamente come pigghiata d'occhiu, questa era una scienza che prevedeva a parte l'esecuzione anche l'interpretazione del risultato che si affiancava sempre ad una sorta di indagine da parte del soggetto che la subiva.
Come in un'escalation verso il paranormale, ancora di meno erano coloro le quali erano specializzate e abilitate ufficialmente a togliere il "malocchio", conosciuta quasi esclusivamente come pigghiata d'occhiu, questa era una scienza che prevedeva a parte l'esecuzione anche l'interpretazione del risultato che si affiancava sempre ad una sorta di indagine da parte del soggetto che la subiva.